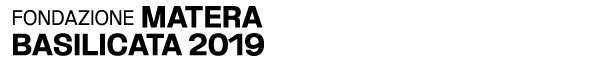Maurizio de Giovanni: un giallo per Matera
*** Aggiornamento del 07 settembre 2015
Potete scaricare il testo completo del giallo materano di Maurizio de Giovanni.
A Natale i seguitissimi momenti di Materadio 2015 della lettura del libro "Le voci della pietra" diventeranno un audiolibro.
Buona lettura! Le voci della pietra
Le voci della pietra
---- ---- ----
In anteprima per Matera 2019, il primo capitolo del giallo materano "Le voci della pietra" scritto appositamente dal famosissimo scrittore Maurizio de Giovanni.
L'intero giallo verrà letto interamente durante le giornate di Materadio 2015 dall'attore Roberto Latini, premio UBU 2014.
... aspettando Materadio, buona lettura!  "Le voci della pietra" di Maurizio de Giovanni - capitolo 1
"Le voci della pietra" di Maurizio de Giovanni - capitolo 1
"Le voci dalla pietra" di Maurizio de Giovanni - capitolo 1
Ci arrivò la sera tardi, dopo un viaggio che gli era sembrato molto più lungo di quello che era stato in realtà. Guidare gli piaceva, ma quella volta gli aveva messo addosso una strana inquietudine. Chilometri e chilometri senza incrociare anima viva, la tarda sera di un giorno feriale in mezzo all’anno; nessuno. Non una stazione di servizio, non qualcuno che accedesse da una via traversa, non un’utilitaria lenta da sorpassare. E la strada, poi; dissestata, difficile, piena di deviazioni; persino alcune crepe nell’asfalto, e la vegetazione che invadeva al di sopra e sotto le strisce di metallo opaco che segnavano il tracciato.
A un certo punto, in prossimità dell’uscita, aveva superato un trattore che impegnava la corsia di destra, marciando a passo d’uomo. Alla guida un tizio con un cappello di paglia, che si era voltato a guardarlo malevolo, come se stesse decidendo se sopportare l’invasione di quella moderna auto blu o mettersi a sparargli con un vecchio fucile da caccia. Gli aveva dato i brividi, quello sguardo.
Ora però che si era sistemato in albergo e che aveva cenato, si sentiva decisamente meglio. La città era carina, pulita e ordinata, pochi negozi ma parecchi bar e ritrovi, gruppi di ragazzi che ridevano e parlavano in un dialetto incomprensibile ma musicale. Camminò pigramente lungo il corso nell’aria dolce, le mani in tasca, per respirare l’atmosfera del posto. Così, quella sarebbe stata la capitale europea della cultura. Certo era isolata, in mezzo allo stivale e resa irraggiungibile da decenni di sudditanza di quella regione al grande nord delle infrastrutture e delle arterie vitali del Paese; ma quel luogo era intrigante, profondamente vero e dotato di un’esclusiva bellezza.
Si fermò nei pressi del belvedere, e rimase senza fiato. Le piccole luci gialle sparse ovunque facevano sembrare un presepe immenso quella che era stata la città antica. I Sassi. Eccoli là. Meravigliosi.
Ai suoi occhi di esperto architetto, specializzato nelle ristrutturazioni degli immobili storici con mantenimento dell’aspetto originario, la distesa di abitazioni, luoghi di ritrovo, chiese, stalle scavati all’interno del fianco della montagna pareva un Paradiso. Il fatto che, come aveva letto, quel posto era stato definito da un leader di partito “vergogna nazionale” era per lui un’ulteriore dimostrazione di quanto i politici fossero ignoranti.
Sospirò profondamente, sorridendo. Non vedeva l’ora che venisse l’indomani mattina, quando il geometra gli avrebbe fatto da guida per inoltrarsi in quel dedalo meraviglioso di viuzze, vicoli e rampe fino al luogo che avrebbero ristrutturato. Avrebbe creato, se lo sentiva, il più originale, straordinario e articolato albergo diffuso d’Italia; e sarebbe stato fantastico sentire di aver partecipato alla costruzione di una vera capitale culturale mondiale, non solo europea. Altro che vergogna nazionale.
Chiuse gli occhi, nel silenzio della notte. Gli parve di sentire il mormorio delle generazioni che erano passate in quelle case. Io vi rispetterò, gli disse. Farò in modo che nulla cambi, nel panorama che si vede da qui.
Si fregò le mani e se ne tornò in albergo. Non vedeva l’ora di cominciare.
Tu lo sai. Io ti ho amato. Ti ho amato tanto.
Mi ricordo come fosse adesso, quando arrivavi da lontano, con quella tua camminata atletica, lo sguardo alto, i capelli che ti ondeggiavano nel vento. Quanto mi piacevi. Eri così bello. Mi pareva assurdo che ti fossi piaciuta proprio io, insignificante come ero, una bambina viziata di città. Chissà cosa ti interessava di me.
A volte sentivo i tuoi occhi addosso, mentre facevo altro; e non mi voltavo per incrociare il tuo sguardo. Ero consapevole che nella tua mente c’erano zone in cui non potevo entrare, che volevi tenere per te; e che comunque non avrei capito. Eravamo così diversi. Non ti chiedevo niente, tu niente mi dicevi. Il fantasma del silenzio che poi ci avrebbe circondato, che ci avrebbe sommerso piano come una marea notturna, buia e muta, cominciava ad aggirarsi attorno a noi già allora, quando cominciavamo ad annusarci, a capire chi saremmo stati l’uno per l’altra.
Dovevo capire. Dovevo sapere. La colpa non è stata tua, sai: è stata solo mia.
Perché io dovevo capire.
Papà? Papà, mi senti?
Lo so, non vuoi che io alzi la voce. Non vuoi nemmeno sentirla, la mia voce. Una volta, ricordi, me lo dicesti perfino, che il mio tono ti infastidiva, che ti distraeva dai tuoi pensieri. Me la ricordo fin da quando ero piccola, questa sensazione. Le volte che eri a casa, e io dovevo smettere di giocare, di guardare la televisione, di ascoltare musica. Ricordo gli occhi della mamma, spalancati di terrore, una muta richiesta di comprensione, forse di aiuto. Stai zitta, mi supplicava. Zitta. E io tacevo, per lei e per me, per non sentire sulla pelle il bruciante dolore della tua cinghia, per non dover sperimentare la terribile combinazione della tua faccia priva di espressione, del tuo sguardo vuoto e della sofferenza delle ferite sulla schiena.
Mi ascolti, papà? Mi senti?
Il geometra era un tipo smilzo, bruno, con pochi capelli e gli occhi vivaci. Saltellava precedendo l’architetto che ne seguiva le misteriose traiettorie, su e giù per strette gradinate e minuscoli vicoli, secondo un itinerario che sarebbe stato impossibile ricostruire a memoria. Durante il cammino, gli parlò dell’immobile che stavano andando a vedere. Vedete, archite’, era l’ultimo sasso che serviva per completare la struttura, proprio in mezzo, capite bene che i lavori non si potevano cominciare finché non si acquisiva. Un sasso grosso, quattro ambienti collegati, e tra i più antichi. Ci stava uno, un vecchio pazzo che non frequentava nessuno, solo qualche volta un bar al centro. Beveva, sì. Uno che aveva fatto il pastore, uno dei tanti.
L’architetto ascoltava con un orecchio solo, mentre cercava non sempre con successo di mantenere l’equilibrio su quel terreno di pietra dissestato. Badava piuttosto all’atmosfera, surreale e senza tempo, come uno scenario artificiale preparato negli studi cinematografici americani. Che straordinario incanto, pensava. Che posto magnifico. Il geometra continuava: e non voleva vendere, archite’. Non so quante volte ci siamo andati, cercando conoscenti suoi, perché di amici non ne aveva manco uno. Sapete, quei vecchi pastori che non capiscono che i tempi sono cambiati? Non ne conoscete? E lo capisco, in città non ce ne stanno, di pastori. Insomma, qua ce ne stanno ancora, e non mollano l’idea della città che hanno, che poi è la stessa idea dei loro nonni e dei loro bisnonni. Non si rendono conto che siamo nel terzo millennio, e che se abbiamo la fortuna di poter avere un quarto d’ora di celebrità, come diceva quel pittore americano, allora la dobbiamo sfruttare, vi pare o no? E se no finisce il momento della capitale della cultura e bla bla e ce ne torniamo nel dimenticatoio, sassi o non sassi.
L’architetto pensava che il geometra aveva ragione. Ricordava la strada lunga e maltenuta che aveva dovuto fare per arrivare fin là, le buche, gli avvallamenti e le crepe che avevano messo a dura prova le sospensioni del suo SUV, il fatto che non ci fosse nei paraggi uno snodo ferroviario degno di questo nome, uno svincolo autostradale e tantomeno un aeroporto; eppure si trattava di un capoluogo di provincia di uno dei sette paesi più industrializzati del mondo, nel continente più antico. Però ora che ci camminava dentro, all’identità antica di quella città, gli ritornava amplificato quel sentimento che aveva sentito la sera prima guardando il panorama dal belvedere: quel posto mormorava. Si sentiva distintamente venire dalle mura di pietra come un indistinto salmodiare, quasi una preghiera; come se al di là di quelle minuscole finestre, dietro quelle antiche porte scrostate ci fosse un intero popolo a osservarli, e a raccontargli un intero milione di storie.
All’improvviso, l’architetto provò un lungo brivido.
Tu mi hai scelta e mi hai presa. Il mio parere non ha mai contato nulla. E del resto non avrei saputo cosa dire: non ero felice e nemmeno triste, mi sentivo destinata a te, e il tuo volere era l’unica condizione sospensiva per essere tua. Ci sposammo di nascosto, né la mia famiglia cercò di ostacolarmi in concreto. Solo mio padre, quando capì le mie intenzioni, cercò di trattenermi: lo guardai negli occhi, con sorpresa lessi inquietudine. Anche lui, ricordi, non era uno che parlava molto. Non disse niente. Io pensai che fosse triste perché aveva capito che me ne stavo andando, perché non avrebbe più avuto con sé la sua bambina.
Oggi so che non era così.
Ma non ebbe la forza di dirmi quello che aveva in mente, e io non ebbi la forza di ascoltare il suo cuore. E un po’ del mio cuore.
Volevo una casa, volevo un uomo e volevo una famiglia. Ero nata per questo. E volevo proprio te.
Papà, mi senti?
Lo so che non mi risponderai. Non mi hai mai risposto.
Non che ti abbia mai chiesto niente, d’altronde. E che avrei dovuto chiederti? Quali argomenti avevamo in comune? La casa, la mamma. Ma tu tornavi e ti mettevi seduto in poltrona, lo sguardo nel vuoto, gli occhi senza niente dentro.
Quegli occhi. Così simili ai miei, così spaventosamente diversi. Una finestra aperta sul nulla, sullo spazio senz’aria che c’è tra le stelle, senza la quiete di un raggio di luce. Il luogo del silenzio erano i tuoi occhi, papà.
Un silenzio che infettava anche la mamma, che pure quando tu non c’eri rinasceva, come risvegliandosi in primavera dopo un lungo, inguaribile inverno. Non che fosse allegra; ma almeno il mento non le tremava di terrore come quando tu mi picchiavi, lo sguardo nel lavandino, le mani bianche per la stretta ad asciugare nervosamente un piatto già asciutto.
Non parlavo di noi a scuola. Mi vergognavo dell’abissale differenza tra il mio mondo e quello delle compagne, che parlavano dei padri con tenerezza, con fastidio o con simpatia. Che ne ridevano, perfino.
Io non avevo niente da ridere.
Arrivarono al complesso che avrebbe dovuto diventare l’albergo diffuso che l’architetto aveva concepito. Il primo sopralluogo normalmente andava fatto prima di immaginare il progetto, ma stavolta i tempi erano stati molto stretti e l’architetto doveva portare a termine un altro lavoro molto complesso che aveva in corso; coi committenti, un gruppo di immobiliaristi e tour operators del nord, era stato chiaro: non potrò andare fin là se non finisco quello che sto facendo. Per cui aveva partecipato a due incontri nei quali gli erano state sottoposte piantine, rilievi e fotografie, nonché una ricostruzione filmata in 3D di quella che era la situazione allo stato e di quello che si immaginava potesse essere l’albergo a lavori finiti. Lui aveva fatto rilevare alcune problematiche e aveva proposto soluzioni; i committenti si erano guardati e avevano deciso che lo avrebbero atteso. Meglio un lavoro fatto bene, con una firma importante come la sua, che sei mesi guadagnati.
Ora che era lì, si rendeva conto una volta di più di quanto fosse inutile osservare i luoghi su carte millimetrate e schermi digitali. La luce. La luce è tutto, e la luce è una cosa viva, mobile, cangiante. Le forme nascono dalla luce e con la luce devono essere compatibili, altrimenti anche la più bella delle idee diventa smorta, inutile. Il popolo che aveva costruito quelle case in qualche modo lo sapeva. Magari senza conoscere lettura o scrittura, senza sapere niente delle quote e delle mappature, aveva trovato il modo di entrare in perfetta sintonia con la luce. Il fianco della montagna che ospitava la città antica sembrava nato così dalle viscere della terra, offrendo quella superficie brulla e bucherellata al cielo e alle nuvole che si inseguivano. Probabilmente i materiali, pensò l’architetto. Forse il fatto di non disporre di mezzi per andare a prendere marmi o vetro; il non sapere cosa fossero la plastica e il cemento armato. Chissà per arrivare a tutto questo quanti crolli di volte, quante mura perimetrali cadute all’improvviso. Sta di fatto che il risultato è perfetto, in termini di compatibilità. Se non fosse stato per quel mormorio. O forse, proprio per quello.
Si rivolse al geometra, chiedendogli quali fossero i confini degli immobili di proprietà dei committenti. Il geometra si asciugò il sudore sulla fronte scura con un gran fazzoletto. Archite’, sono dieci case, tutte collegate tra loro. L’ultima, quella del pastore che vi dicevo prima, da qua non si vede, si deve salire per quella scala, è un po’ discosta dalle altre, l’unica non confinante; ma è pure l’unica che vede tutta la valle. L’idea, da quello che ho capito, è di farci una suite a prezzo maggiorato. Vediamo prima qua, poi vi ci porto.
Sai, fui addirittura contenta quando smettesti di salire al pascolo, limitandoti ad accudire i nostri animali. Adesso sembra assurdo dirlo, ma ne fui contenta.
Certo, lo avevi fatto solo per quella maledetta caduta da cui non ti eri mai veramente ripreso, non lo avresti desiderato, e perciò si acuirono il tuo nervosismo e i tuoi silenzi; ma così eri sempre a casa, e potevi finalmente dormire di più. Saremmo stati più tempo insieme, avrei potuto lenire con dolcezza i tuoi tormenti che non capivo, che non mi lasciavi conoscere.
Invece. Invece.
Ma non potevo saperlo, allora.
Volevo un figlio, lo volevo con tutte le mie forze. Pensavo di volerlo per me, perché mi sentivo madre da sempre, lo avevo nel sangue e nelle viscere di essere chiamata mamma. Ma senza saperlo lo volevo per noi due. Immaginavo che attorno a una culla saremmo diventati qualcos’altro, due genitori, una famiglia. Che il velo che si ispessiva ogni giorno tra te e me sarebbe caduto, che avrei visto il tuo sorriso.
Qualche volta all’inizio mi parlavi del tuo lavoro. Mi descrivevi la bellezza della natura, il verde dei pascoli, il silenzio assoluto, le lunghe camminate senza fretta e senza meta. E mi dicevi del peso della solitudine, delle difficoltà economiche, dell’incertezza del futuro e anche del presente.
Quando nacque nostra figlia fui felice. Ricordo che tenendola tra le braccia mi voltai verso di te, per leggere nei tuoi occhi almeno una volta la felicità, l’orgoglio e un po’ di fiducia.
Guardavi altrove. La fronte corrugata, gli angoli della bocca lontanissimi da qualsiasi sorriso.
Il buio cominciava a inghiottire la tua anima.
Papà? Almeno adesso puoi ascoltarmi, papà?
Chissà se mi stai sentendo. Non lo so. Non l’ho mai saputo, quanto mi ascoltassi, le rare volte che trovavo il coraggio di parlarti. Crescevo, diventavo donna attorno a te e tu non mi vedevi. Avevo imparato alla fine quanto mi convenisse che tu non mi vedevi. Niente sguardo addosso, e niente dolore sulla schiena.
Col tempo ci si abitua a tutto, sai, papà? Ci si abitua.
Io per esempio mi ero abituata a non avere una vita.
Avevi detto alla mamma che non ti piaceva che io stessi fuori di casa se non per la scuola. Che il mondo era un posto terribile. Che l’unica certezza, l’unica sicurezza era nelle mura di casa.
Dicesti proprio così: nelle mura di casa. A ripensarci è proprio divertente, vero, papà?
Passarono l’intera mattinata a osservare metro per metro le unità acquisite. L’architetto si congratulò con se stesso per aver concepito un embrione di progetto per nulla invasivo, che avrebbe coniugato modernità e comodità col rispetto assoluto di come si presentavano i sassi alla vista, anche in maniera più rigorosa di quanto prevedessero i vincoli paesaggistici.
L’albergo sarebbe stato bellissimo, anche se per forza di cose il personale avrebbe dovuto sottoporsi a percorsi un po’ meno intuitivi e semplici di quanto fosse in genere per una struttura di lusso; ma a qualcosa bisognava pur rinunciare.
Quando il sole ormai stava per tramontare in un trionfo di rosso, arancione e azzurro, il geometra condusse l’architetto in cima a una stretta rampa di gradini alla fine dei quali c’era una pesante porta in legno, chiusa. Soddisfatto, l’ometto si voltò sorridendo e disse: eccoci qua, archite’. Questa è l’unità appena acquisita, quella che diventerà la suite. Guardate che vista, tiene.
Effettivamente agli occhi dell’architetto, che si voltò a guardare, si presentò un panorama che lasciava senza fiato. I tetti, le mura, sembravano un unico dorso di un immenso animale addormentato e si distendevano verso l’orizzonte. Il sole bassissimo inondava di fuoco lo spazio, creando l’impressione di un territorio limite tra l’inferno e il paradiso. Si voltò sorridendo e chiese al geometra se arrivare proprio là a quell’ora fosse una recita programmata. L’ometto annuì, serio: la verità? Sì, archite’. Perché certe cose se non le si guarda nella giusta luce, diciamo, non si capiscono. Non credete?
Fu in quel momento che all’architetto arrivò, chiaro, il mormorio che fino ad allora era sembrato indistinto. Fu talmente forte che si girò a guardare la porta chiusa, come rispondendo a un richiamo. Chiese: ma c’è qualcuno? C’è ancora qualcuno, qui? Il geometra lo fissò perplesso: no, archite’, nessuno. Ci stava solo quell’uomo, ve l’ho detto, ma è morto e lo hanno pure seppellito, ormai sono mesi, non ci sta proprio più nessuno, né qua né nelle altre unità che la società ha comprato. Ma che è, non vi sentite bene?
L’architetto scosse il capo. Non sentiva più alcun rumore, ma vide un gatto uscire dalla sommità della rampa, stiracchiarsi e saltare giù da un muro, sparendo. No, disse; ho un po’ di mal di testa, e quel gatto… Mi sembrava di aver sentito qualcosa. Comunque sì, una vista decisamente magica. Se dev’esserci una suite, non può essere che questa. Però all’interno la vediamo domattina, adesso non c’è abbastanza luce. E un’altra cosa, geometra: vorrei la storia di questo posto. Sapere di quest’uomo, della sua vita. Ci riesce, a informarsi?
Non avevo il coraggio. Non l’avevo mai avuto, in realtà. Mi accorgevo di quello che stavi facendo a nostra figlia, di quanto la stessi rinchiudendo in una gabbia senza finestre, di quanto sarebbe stata incapace di affrontare il mondo se non l’avesse mai conosciuto; ma non eri mai stato così fermo e deciso e io che non ti avevo contraddetto nemmeno sulle sciocchezze, non avevo la forza di contrappormi.
Cercavo di parlare con lei, almeno quando tu non c’eri; e avevamo sviluppato un linguaggio nel silenzio, fatto di cenni, di sguardi alle tue spalle. A lei cercavo di giustificare il tuo pensiero. Le dicevo che eri stato male e che noi avevamo il dovere di aiutarti, lasciandoti tranquillo, dandoti un po’ di serenità almeno tra queste mura.
Tra queste mura.
Che Dio mi perdoni.
Papà? Mi ascolti, papà?
Ricordi quando mi portasti lui, qui a casa?
Ero grande, ormai. A scuola non ci dovevo più andare, e non c’erano più feste di compleanno alle quali ero invitata ma dovevo rifiutare, con qualche assurda scusa.
Avevi deciso che ormai ero una donna. Che avevo bisogno di un marito, per fare un figlio, per darti un nipote. All’improvviso avevi l’ossessione del tempo, la necessità di guadagnarti attraverso me un pezzo di sopravvivenza dopo la morte.
E mi portasti lui.
Aveva lavorato con te. Robusto, alto: ti aveva aiutato quando ancora riuscivi anche se con difficoltà a inerpicarti. Mi faceva paura, da principio. Poi mi accorsi che anche nei suoi occhi vibrava il terrore che conoscevo così bene, la sottoposizione vuota di volontà che vedevo ogni giorno negli occhi di mia madre.
Andai con lui. Una pantomima di matrimonio tra sconosciuti, qualche interdetto parente. L’unica fotografia, sulla credenza, fissa i nostri occhi senza espressione: io, tu, lui. Solo la mamma sembra disperata. Incredibile quanto ci somigliamo, vero, papà? Quanto ci somigliamo, senza assomigliarci affatto.
Durò poco. Cambiasti idea, quasi subito. Non potevi controllarci a sufficienza, in un’altra casa; anche se lui come te non diceva una parola, anche se il suo sguardo terrorizzato non mi sfiorava nemmeno, anche se la mia vita non era cambiata in niente col matrimonio.
Mi riportò a casa, una mattina. E poi riportò anche le mie cose. Senza una parola, senza una spiegazione. Ma non ce n’era bisogno, no, papà? Nel tuo sguardo gelido, nel tuo cenno d’assenso c’erano tutte le spiegazioni necessarie.
Tutto quello che c’era da sapere.
Il geometra sembrava un po’ a disagio, quando si rividero la mattina dopo. Il cielo era grigio, fermo, e la cappa di calore pesava come un sudario sulle pietre silenziose. L’ometto si asciugava continuamente la fronte, e gli occhi neri dardeggiavano attorno senza mai soffermarsi su qualcosa in particolare. In silenzio condusse l’architetto e un manovale armato di piccone fino alla porta di legno chiusa, poi si fermò e rivolse lo sguardo al professionista.
Archite’, disse, voi ieri mi avete chiesto di prendere notizie sull’uomo che abitava qua. Io ho chiesto in giro, e qualcosa mi hanno detto. Volete sentire prima o dopo?
L’architetto lo fissò perplesso. Non capiva il senso della domanda. Che volete dire, geometra? Era una curiosità, non è che conti rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Vediamo prima l’interno, poi magari mi dite. Ma come mai avete portato il muratore, con noi?
Il geometra fece una smorfia imbarazzata. Vi ho detto che il proprietario non voleva vendere, disse. Non so quante volte gli abbiamo fatto offerte, e lui ha sempre detto di no. poi all’improvviso è morto, anzi: lo hanno trovato morto. Chissà da quanto tempo era successo, era praticamente diventato una mummia; ma siccome non frequentava nessuno, nessuno se n’era accorto. Insomma, ha lasciato la casa al Comune, e il Comune ha subito venduto alla società. Io conosco la pianta catastale, ma qua dentro non sono mai entrato. La porta è stata chiusa, ma le chiavi non ci stanno da nessuna parte; Peppino col piccone, qua, serve per aprire.
Fece un cenno al manovale che annuì, si avvicinò alla porta e aprì con un paio di colpi alla serratura arrugginita.
Entrarono cercando di abituare gli occhi all’oscurità. Le stanze davano una nell’altra, pochissimi i mobili, di legno pesante e antico. Qualche vecchio giornale. Ragnatele. Odore di vecchio, un tanfo di muffa che copriva il rancido di qualche alimento andato a male.
L’architetto quasi istantaneamente sentì ronzare nelle orecchie il mormorio che lo aveva accompagnato il giorno prima. Si passò una mano davanti agli occhi e sospirò.
Poi disse al geometra: mi racconti di quest’uomo. Mi racconti adesso.
Quando la vidi tornare a casa mi successe qualcosa nel cuore.
Avevo sopportato tutto; ho sopportato tutto. L’amore prima, l’inerzia e la paura poi mi avevano anestetizzato ogni volontà, ammesso che ne abbia avuta mai: ma vedere mia figlia, l’unica cosa bella della mia vita, l’unica dolcezza, l’unica tenerezza che mi era stata riservata ridotta a un animale senza futuro mi fece trovare una forza che non sapevo di avere.
Ci avevo sperato, quando tu stesso decidesti che doveva avere una sua vita, un marito, una casa. Che volevi un nipote, qualcuno che desse un futuro a te stesso dopo di te. Avevo sperato che le toccasse un diverso destino, che avesse un’esistenza lontano dalle tue terribili mani e dalla follia che ti aveva invaso.
E invece era di nuovo là, con l’anima spezzata, tra queste mura. E tu di nuovo col tuo buio su di lei.
Attesi la sera in cui sapevo che saresti andato a giocare a carte con gli unici due amici che avevi, meglio le uniche due persone che ancora ti frequentavano. Forse portatori dello stesso sentimento di paura, se non di terrore. Sapevo che avresti bevuto e che avresti tirato fino all’alba. Attesi con freddezza, attenta a non dare a nessun mio gesto una connotazione nuova, diversa; consapevole della tua diabolica capacità di annusare l’aria, di riconoscere le emozioni come fossero un sapore, un mefitico odore. Raccolsi le poche cose necessarie, le misi in una borsa. Pensai che saremmo andate da mio fratello, lontano, anche se non lo vedevo da anni. Che da là saremmo andate ancora più lontano, in America, in Africa; che avremmo provato a vedere se c’era spazio per la vita, nel nostro tempo. Per lei, non per me.
Quando, appena fuori la porta, è arrivato il colpo dietro la mia testa ho avuto solo un attimo per pensare in che cosa mi fossi tradita, da che cosa avessi capito.
Papà? Lo sai, papà? Io me lo aspettavo.
Non ho mai pensato che ci saremmo riuscite. Lo avevo visto, che guardavi le chiavi dello sgabuzzino appese sull’altro chiodo, a pochi centimetri di distanza da quello solito. Che da quello, in un lampo, avevi capito che la mamma aveva cercato la borsa grande, l’unica cosa che poteva volere là dentro. Lo sai, io e te ci assomigliamo. Non solo negli occhi, anche nei pensieri.
E perché non gliel’ho detto? Facile, papà: perché volevo che ci provasse. Perché se avesse saputo che c’era una possibilità, una sola, che tu ti accorgessi di qualcosa, non l’avrebbe mai fatto. E’ vile, la mamma, tu lo sai, papà. Non ha nessun coraggio.
Dovevamo provarci. Lo capisci, papà? Almeno provarci.
Peccato.
Il geometra prese una sedia un po’ sgangherata e si accomodò. Tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette sgualcito e fece un cenno verso l’architetto, che scosse il capo. Poi cominciò a parlare.
Si chiamava Felice. Un nome strano, tenuto conto che nessuno mai l’ha visto ridere, a quanto mi dicono. Vi ho già detto che teneva un brutto carattere, praticamente senza amici, la generazione sua per il grosso è emigrata e quelli che sono rimasti si sono arrangiati: erano anni difficili. Pure Felice ci provò, ma dopo qualche mese se ne tornò perché in città non trovò niente. Anzi, qualcosa trovò: una moglie. Una ragazza bella, mi ha detto il barista, ma che si vedeva pochissimo in giro perché il marito era gelosissimo. Una gelosia malata, archite’: di quelle che tolgono il respiro a chi la prova e a chi la subisce. Insomma, pare che per via di questa gelosia un giorno Felice volle tornare a casa dal pascolo prima del tempo, camminando di notte. Cadde e si spezzò una gamba. Allora non era come a mo’, che te la rimettono a posto in quattro e quattr’otto. Lui rimase zoppo, e questo lo incattivì ulteriormente. Mi ha raccontato sempre il barista che certe volte si sentivano rumori che venivano da qua dentro, come se qualcuno spaccasse la legna con rabbia.
Come che fu, ebbero una figlia. Una ragazza che mandarono a scuola, ma che come il padre non fece amicizia con nessuno. Poi la ragazza si sposò, ma… Ma?, chiese l’architetto. Non so, rispose incerto il geometra spegnendo a terra la cicca. Dev’essere successo qualcosa, il barista è stato vago e i vecchi che stavano nel bar non hanno aggiunto una parola. Mi hanno detto che la ragazza è tornata a casa, dal padre e dalla madre. Ma sono cose successe molti anni fa, quindi non ci giurerei. Io vi posso dire che per farmi raccontare la storia mi sono dovuto bere una bottiglia intera di vino, e stamattina tengo un mal di testa da competizione.
Comunque dopo pochissimo la moglie e la figlia sono scomparse. In che senso, scomparse?, chiese l’architetto. Nel senso che non si sono viste più, e le rare volte che Felice usciva da casa per andare a comprare qualcosa si trattava di quantità minime. Per una persona sola, insomma.
E nessuno gli ha chiesto niente? La voce dell’architetto era bassa, come se avesse paura di essere sentito da qualcuno. La testa era piena del fastidioso mormorio. Certo che gliel’hanno chiesto, rispose il geometra. In questa città ognuno si fa i fatti suoi, d’accordo, ma solo in apparenza. Siamo troppo pochi per non accorgerci che la gente non ci sta più dalla sera alla mattina. E lui, Felice, raccontò che la moglie aveva deciso di tornarsene in città, dai parenti suoi; e che la figlia l’aveva seguita. Si conosceva il carattere dell’uomo, e nessuno gli diede torto alle due donne ad essersene andate. Lui, da parte sua, pareva che se ne fregasse. Ma forse voleva solo far vedere, e dentro ci soffriva. Chi lo sa. Poi, dopo alcuni anni, è morto pure lui, in solitudine. Il barista mi ha anche detto che qualcuno avrebbe voluto avvertire la moglie, ma non si sa niente, neppure come si chiama. Perciò, dopo un po’, si sono rassegnati tutti quanti ed è finita la storia.
Dopo un attimo, l’architetto si alzò e si guardò di nuovo attorno. Corrugò la fronte, aguzzando la vista nella penombra.
Poi disse: e questo cos’è?
Mi sono svegliata qui. La testa mi pulsa, sento il sangue colarmi sul collo. L’odore della calce, il buio, il silenzio. Il bavaglio sulla bocca mi fa respirare con difficoltà, le mani e i piedi legati toccano pareti attorno. Che posto è questo?
Sento l’odore di lei, di nostra figlia. La tocco, a pochi centimetri da me. E’ calma, non si muove, ma respira regolarmente. Non risponde ai miei gemiti disperati, sento solo il mio mugolio da gatta, come in quei sogni in cui vorresti urlare e la voce non viene fuori.
Perdo forza. Cado nel vuoto.
Ti ho visto, sai, papà? Apprezzo che, anche legata e imbavagliata, tu mi abbia lasciato vedere mentre preparavi la calce, le pietre.
E capisco tutto, capisco che lo fai per noi. Che la sicurezza che volevi per la tua famiglia, la protezione dal mondo può essere in fondo qui, solo qui.
In queste mura.
Il geometra seguì lo sguardo dell’architetto e chiese: che cosa?
Qui, indicò l’uomo. Questa parete, non vedete? Il geometra si avvicinò al muro e capì quello che l’architetto tentava di indicargli: la parete tra la prima e la seconda stanza mostrava un dislivello, come un gradino. Picchiettò prima col tacco della scarpa, poi con le nocche della mano. Nel silenzio il rimbombo suonò profondo. E’ vuoto, archite’, disse. E fece cenno al muratore, che si appressò col piccone.
Anche l’architetto si avvicinò, e all’improvviso il sordo rumore di voci sommesse che faceva da sfondo ai suoi pensieri spezzandoli e rendendoli monchi cessò.
Continua ... vi aspettiamo a Matera, il 4, 5 e 6 settembre!